I ragazzi della nave
Nella lattiginosa luce del Circolo Polare, il battello “Forsete” entrò nel porto di Longyearbyen, nelle isole Svalbard, il pomeriggio del 24 settembre 1918. Sbarcano in fretta i passeggeri: pescatori norvegesi che, come ogni inverno, si recano a lavorare nelle miniere dell’isola. Ma non tutti: Hans, Ole, Magnus, Tormod, Johan, Williani e Kristian continuano a giacere, febbricitanti, avvolti in coperte sul ponte della nave. Hanno tra i 19 e i 27 anni e i loro corpi, fino qualche giorno prima pieni di vigore, sono ora flaccidi, stremati e dalla pelle divenuta diafana continua a spurgarsi un sudore biancastro, appiccicoso, caldissimo. Con un filo di voce supplicano aiuto ma c’è il vuoto intorno a loro. Infine, qualcuno li trasporta in una casupola di legno a fianco della chiesetta di Longyearbyen e lì, con i polmoni soffocati dal sangue, trovano la morte. La notizia fa in un attimo il giro dell’isola e, tra le centinaia di minatori, una parola carica di terrore passa di bocca in bocca: “Spagnola”
L’epidemia era stata chiamata così perché solo in Spagna, fuori dalla Prima Guerra Mondiale, l’infezione aveva trovato spazio sui giornali liberi dalla censura militare. Ma da dove sia venuta quell’epidemia è ancora oggi un mistero. Di certo oggi sappiamo che in sei mesi colpì un miliardo di esseri umani uccidendone almeno 21 milioni, 375.000 nella sola Italia. Il morbo cominciava come una “normale” influenza: tosse, dolori lombari, torpore, febbre… poi subentravano dolori lancinanti, sudore intenso, febbre altissima, distruzione dei tessuti, muco e sangue nei polmoni. La morte arrivava in pochi giorni. Così muoiono tre milioni di persone in Europa; così muoiono i sette ragazzi sbarcati a Longyearbyen.
Per tre giorni, nessuno ha il coraggio di avvicinarsi a quei cadaveri che qualcuno propone di distruggere dando fuoco alla casupola. Infine un minatore, mosso a pietà, fora con un trapano lo strato perennemente congelato che sovrasta l’isola, il permafrost, e nella stretta buca inserisce una carica di dinamite; l’esplosione scava una fossa profonda tre metri nella quale deposita i sette corpi.
Resteranno lì per ottanta anni fin quando, nell’agosto 1998, le loro tracce appaiono sul monitor di un georadar GBR (Ground Penetrating Radar). Finalmente la dottoressa Kirsty Duncan ha trovato il suo tesoro. Per cinque anni questa paleopatologa canadese ha scartabellato libri e polverosi archivi per localizzare corpi uccisi dalla “Spagnola” che, essendo stati sepolti in terreni perennemente ghiacciati, possono conservare tracce del virus. O, addirittura, il virus ancora vivo. Anche per questo la riesumazione dei corpi sembra la scena di un film di fantascienza. Sul luogo dello scavo viene eretta una struttura ermetica a depressione per scongiurare una eventuale diffusione verso l’esterno di microrganismi Lì il dottor Charles R. Smith, sigillato in una spettrale tuta bianca, completa di casco e autorespiratore, si china nella fossa appena scavata e con una sonda estrae dai cadaveri congelati brandelli di tessuto polmonare, pezzi di fegato, di milza. I reperti, chiusi in doppi contenitori di acciaio, vengono portati con urgenza nei laboratori di massima sicurezza P4 dell’Università di Toronto per essere analizzati. Intanto una paura comincia a serpeggiare sui mass media: e se il virus dell’influenza spagnola ibernato da ottanta anni nel ghiaccio si risvegliasse?
Il morbo dal passato
Il primo biologo a parlare di “criptobiosi”, (e cioè la possibilità per i microrganismi di ritornare alla vita, quando si ripristinano favorevoli condizioni ambientali, dopo un lunghissimo periodo nel quale non hanno dimostrato alcuna attività metabolica) fu, più di cinquanta anni fa, Charles Lipman, dell’Università di Berkeley. All’interno di un mattone di una stanza della missione di San Luis Obispo, in California, egli riscontrò batteri viventi in una quantità superiore a 100 milioni per grammo. La stanza era stata usata fino a un secolo prima come prigione, per poi essere sigillata e mai più aperta. Erano batteri con una eccezionale capacità di sopravvivenza, come asseriva Lipman, o contaminazioni da parte di batteri recenti, come sostenevano i suoi detrattori? La disputa sembrò virare a favore di Lipman quando, negli anni sessanta Peter Sneath, biologo dell’Istituto nazionale per la ricerca medica di Mill Hill, a Londra sconvolse il mondo scientifico dimostrando che parte della sospensione di spore di Bacillus antracis preparata da Pasteur nel 1880 era ancora “viva”. Questa scoperta diede impulso alla ricerca sulla criptobiosi e le sorprese non mancarono. Qualche anno dopo, ad esempio, furono scoperte spore viventi in una scatola di carne confezionata 118 anni prima mentre fu possibile “resuscitare” bacilli coliformi, presenti nei resti congelati delle feci sparse dai pony che parteciparono alla missione nell’Antartide del 1912 guidata da Robert Falcon Scott.
Alcuni microrganismi possono sopravvivere ad eccezionali condizioni di siccità o elevata temperatura trasformandosi in spore, rinchiudendosi, cioè, di una specie di bozzolo. Altrettanto affascinante è il meccanismo che permette ad altri microrganismi di perpetuarsi a basse temperature. Come è noto, il freddo uccide le cellule facendone scoppiare l’involucro; tuttavia, quando un grande numero di batteri è ucciso in questa maniera, le prime cellule morenti possono liberare una quantità sufficiente di sostanze crioprotettive. Se tali sostanze vengono rilasciate in una popolazione cellulare di elevata densità e raggiungono una concentrazione appropriata nei tempi giusti, possono salvare almeno una piccola parte delle altre. Prove sperimentali dimostrano, ad esempio, che quando i batteri vengono congelati in presenza di un buon crioprotettivo, come il glicerolo, quasi tutti inizialmente sopravvivono; la morte poi sfoltisce il gruppo ma, partendo da un miliardo di unità, alcuni possono sopravvivere per più di un secolo.
Ma anche a temperature prossime allo zero il comportamento dei germi può essere sbalorditivo.
Nel 1975 ricercatori dell’Università di Bradford in Gran Bretagna trovarono spore vitali di un batterio termofilico (non capace di riprodursi al di sotto dei 35 gradi), il Thermoaclinomyces, murate nelle rovine del forte romano di Vindolandia, nei pressi del vallo di Adriano. Spore dello stesso germe furono successivamente trovate da biologi statunitensi nei sedimenti stratificati dei laghi del Minnesota: qui la concentrazione più elevata di spore apparteneva a uno strato risalente a più di 5.000 anni fa. Un altro batterio termofilico, il Bacillus stearothermophilus, è stato scoperto, da George Paik dell’Università della California meridionale in sedimenti del Pacifico antichi almeno ottomila anni che da sempre hanno sempre avuto una temperatura di 4 gradi. Questo batterio, inoltre è del tutto incapace di moltiplicarsi nell’acqua salata. Non resta che una spiegazione: le spore si sono depositate sul fondo oceanico quando questo si stava formando e sono lì sopravvissute per 5.000 anni.
Ma è possibile che virus inseriti in microrganismi ibernati o mummificati possano ritornare attivi? O che, addirittura, alcuni virus possano, fuori dalle cellule, perpetuarsi tornando attivi quando le condizioni ambientali diventano favorevoli? C’è stato chi come il premio Nobel Francis Crick (scopritore, con James Watson, del DNA) si è spinto più in là teorizzando che virus veicolati dalle comete abbiano potuto attraversare gli spazi siderali e giungere sul nostro pianeta; una ipotesi questa, sostenuta fino a qualche anno fa dall’astrofisico Fred Hoyle e da pochi altri “eretici” ma che oggi comincia a trovare crescenti consensi nel mondo scientifico.
Ma, allora, è, davvero pericoloso riesumare corpi uccisi, anche se secoli fa, da temibili infezioni? In Italia, tempo fa, suscitò scalpore l’allarme – istituzionalizzato da un articolo dall’autorevole rivista <<Lancet>> – che il vaiolo potesse diffondersi a seguito dell’apertura di un sarcofago, contenente la mummia di un vaioloso della seconda metà del sedicesimo secolo, custodito nella basilica di San Domenico Maggiore a Napoli. Il paleopatologo che eseguì lo studio sulla mummia è il professore Gino Fornaciari dell’Università di Pisa. Nonostante il suo aspetto mite è considerato l’“Indiana Jones dei microbi”. Tra i suoi “pazienti” più famosi Gregorio VII, Sant’Antonio da Padova, Andrea Mantegna, Enrico VII, Re Ferrante I di Aragona… e una infinità di mummie egiziane, peruviane, italiane.
<<Professore Fornaciari, con il suo lavoro quali sono i rischi di “resuscitare” un’infezione?>>
<<Fino a qualche anno fa c’era una apprensione che oggi è ritenuta ingiustificata. Attualmente, ad esempio, non è più consigliata la vaccinazione antivaiolosa ai paleopatologi che operano su mummie recenti. Ovviamente una possibile infezione “di ritorno” non è da escludere in linea del tutto teorica e, per questo, anche operando su reperti risalenti a secoli addietro, vengono messe in atto numerose misure profilattiche. In qualche caso, le mummie sono preventivamente irradiate con dosi massicce di raggi gamma per uccidere ogni possibile forma di vita, ad esempio muffe che, se inalate, possono costituire pericolo di gravi infezioni. Ma non tutti i paleopatologi sono d’accordo con questa misura profilattica: nel caso della mummia di Ramsete, ad esempio, l’irradiazione con raggi gamma ha compromesso una possibile analisi del DNA del faraone. Ovviamente se lo scopo del paleopatologo fosse quello di recuperare un antico microrganismo – che, in linea del tutto teorica, potrebbe essere ancora “vivo” – l’irradiazione con raggi gamma non potrebbe essere attuata e si dovrebbero mettere in atto rigidissime misure di contenimento delle salme e dei reperti da queste estratte.>>
<<Ma come è possibile identificare tracce di virus in corpi deceduti da secoli?>>
<<Con tanta pazienza e tantissima fortuna. Ad esempio, nella mummia di un bambino napoletano morto nel XVI secolo, dopo innumerevoli osservazioni andate a vuoto, siamo riusciti ad osservare con il microscopio elettronico strutture ovoidali, della grandezza di 250 nanometri, costituite da una zona centrale più elettrondensa circondata da un alone a più bassa densità. Le dimensioni e la morfologia erano compatibili con quelle di alcuni grossi virus, quali appunto il poxvirus responsabile del vaiolo. Le strutture quindi, previa incubazione con antisiero contro il virus vaccinico umano, sono state esposte al complesso proteina-A-oro colloidale, che evidenzia la presenza di gammaglobuline e quindi l’avvenuta reazione antigene-anticorpo. Dopo questa reazione, le particelle virali sono apparse completamente ricoperte dal complesso proteinaA-oro colloidale dimostrando così l’avvenuta reazione antigeneanticorpo. Così abbiamo avuto la certezza che quelle strutture ovoidali erano state un tempo virus del vaiolo.>>
<<La scoperta di quale epidemia del passato è oggi la meta più ambita per un paleopatologo?>>
<<La storia è piena di devastanti epidemie che sono scomparse senza lasciare traccia. La cosiddetta “Peste di Atene” del 430 a.C., narrataci da Tucidide, ad esempio. O il “Sudore anglico” apparso in Inghilterra nel sedicesimo secolo. Ma, forse, intrigante più di tutti è la questione sull’origine della sifilide che, secondo alcuni sarebbe stata “importata” dalle Americhe, secondo altri, invece, si sarebbe originata nel Vecchio Mondo. E se da una parte o l’altra dell’Atlantico trovassimo una mummia antecedente al 1492 con i segni della sifilide (le cui tracce vengono oggi evidenziate usando un anticorpo antitreponema e la tecnica dell’immunofluorescenza) la questione della sua origine potrebbe dirsi risolta.>>
SECONDA PARTE (DEDICATA ALL’INFLUENZA)
Il destino dei maiali
Il dottor J. S. Koen, ispettore del servizio di controllo peste suina del Ministero dell’Agricoltura USA, si chinò e pungolò un’altra volta il maiale, ma invano. L’animale, sdraiato su un fianco, continuava a starsene immobile ansimando, coperto di sudore, con gli occhi chiusi. Non era il solo maiale in quelle condizioni, scriverà più tardi Koen nelle sue memorie. Alle otto di sera di lunedì 10 settembre, a Cedar Rapids nello Iowa, l’Esposizione Nazionale degli Allevatori di Suini stava avvicinandosi alla triste conclusione del suo giorno inaugurale. Nei recinti espositivi del William Holland Building, migliaia di maiali delle razze piú pregiate (alcuni raggiungevano un valore di quindicimila dollari al capo) giacevano prostrati sui trucioli di legno di ginepro, ansimando penosamente, tormentati di tanto in tanto da una brusca tosse secca. L’esposizione chiuse prematuramente e gli espositori se ne tornarono alle loro fattorie portando con sé quegli animali che erano in condizioni di rifare il viaggio verso casa. Così l’infezione si sparse dappertutto e, ben presto, milioni di maiali, nello Iowa nel Middle West in tutto il pianeta, si ammalarono e cominciarono a morire.
Secondo alcuni ricercatori proprio dalla esposizione suina di Cedar Rapids partì l’influenza “Spagnola” che uccise almeno 21 milioni di esseri umani; le altre epidemie influenzali, invece, (uno studioso, Eric Hirsch, ha calcolato un totale di 299 epidemie influenzali umane tra il 1173 e il 1875) sono nate e continuano a nascere nella Cina meridionale. Lì, infatti, in innumerevoli fattorie, vengono allevate anatre e maiali; gli escrementi provenienti da una specie vengono utilizzati come fertilizzante per produrre il cibo destinato a un’altra specie e così il virus dell’influenza di tipo A si trasmette dalle anatre al maiale il quale, avendo recettori sia per il virus umano sia per quello degli uccelli, funge da “shaker” trasformando il virus degli uccelli in uno capace di infettare l’uomo. La mobilità delle persone garantisce la diffusione dell’epidemia che ogni anno colpisce tra il 10 ed il 20% della popolazione mondiale, generalmente senza gravissime conseguenze; tuttavia, ogni dieci-vent’anni, fa la sua comparsa un ceppo virale fortemente mutato, contro il quale nessuno ha potuto sviluppare anticorpi. Nascono così devastanti epidemie di influenza come la “Spagnola” del 1918, l’”Asiatica” del 1957 (colpì il 50 per cento degli abitanti del pianeta e fece 70.000 morti nei soli Stati Uniti), la “Cinese” del 1968…
Quali mutazioni deve conoscere il virus dell’influenza per diventare così pericoloso? A Londra il 15 novembre 1999 nel convegno “Influenza: Past, Present and Future – Genetics of Virulence and Pathogenicity of Influenza, il professore John Oxford ha presentato i risultati degli studi condotti dai paleopatologi sui corpi rinvenuti a Longyearbyen e su due soldati e una donna morti di “Spagnola” e seppelliti nel ghiaccio dell’Alaska. <<Purtroppo, – ci ha detto Oxford – i corpi recuperati si sono rivelati troppo deteriorati e del virus dell’influenza non restano che alcuni frammenti. Dal puzzle di questi virologi e paleopatologi sono riusciti, comunque, a ricostruire un quadro che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per affrontare le future epidemie influenzali. Per la prima volta, infatti, è stato mappato un gene fondamentale del virus killer, quello che codifica l’emagglutinina; ha una struttura molto simile al gene umano che codifica la stessa proteina. Questo significa che il virus della “Spagnola” non ha compiuto quel tipico “salto di specie” che avviene di solito nelle epidemie di influenza, passando dagli uccelli ai suini e poi alla specie umana ma era già annidato nei mammiferi (maiali o esseri umani) da quasi vent’anni nel corso dei quali avrebbe sviluppato quelle mutazioni che lo hanno reso un flagello per l’umanità. Queste informazioni potrebbero rivelarsi di grande importanza per affrontare le future epidemie di influenza che si abbatteranno nei prossimi anni sull’umanità e che rischiano di riproporre le stesse devastazioni della “Spagnola” per una inaspettata evoluzione del virus.>>
Un allarme in tal senso si è avuto nel 1997 a Hong Kong. Lì un virus dell’influenza – l’H5N1- diffuso tra i volatili, in particolare tra i polli, ha saltato la barriera della specie trasmettendosi direttamente all’uomo, senza passare cioè per i maiali – tradizionali “serbatoi di adattamento” del virus alla specie umana – uccidendo sette persone. La risposta delle autorità sanitarie è stata, per fortuna, tempestiva ed efficace. Mentre nella Cina continentale venivano uccisi e seppelliti più di un milione di polli, a Hong Kong veniva chiuso a tempo indeterminato il mercato all’ingrosso di pollame di Cheung Sha Wan. Contemporaneamente le circa settanta persone risultate infettate dal virus H5N1 sono state trattate con un farmaco antivirale, – l’amantadina, finora poco utilizzato a causa dei suoi gravi effetti collaterali – e quella che poteva essere una devastante epidemia, grazie anche ad uno sforzo eccezionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata stroncata sul nascere.
Articolo di Francesco Santoianni
Pubblicato su Newton dicembre 1999
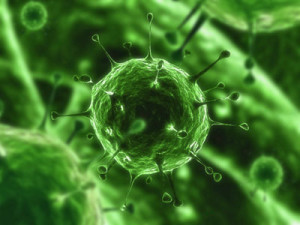
Pingback:Le Svalbard – le isole norvegesi vicine al polo Nord dove si conservano i semi del mondo e dove tutto è diverso da come siamo abituati. | Diario Nordico